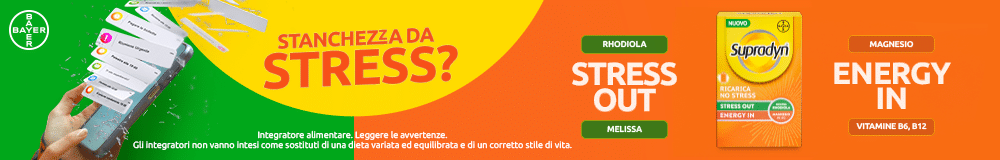Covid-19

Dopo il COVID ti senti
più stanco del solito?
Ecco il perché

Senso di spossatezza, necessità di dormire anche durante il giorno, mancanza di energia per svolgere il normale esercizio fisico. Si tratta della fatica cronica da long COVID.
Con il termine long COVID si indica una serie di segni (alterazioni osservabili con un esame medico) e sintomi che continuano a manifestarsi, saltuariamente o in modo continuativo, anche dopo la guarigione dall’infezione acuta da Sars-Cov-2.
Tra i disturbi osservati più di frequente, vi è proprio la sensazione di spossatezza, che somiglia per alcune caratteristiche alla sindrome da stanchezza cronica che si presenta anche in seguito ad altre infezioni, come la mononucleosi, o all’incontro con virus molto pericolosi, tra cui Ebola o Chikungunya.
La stanchezza da long COVID può avere un grosso impatto sulla vita di chi ne soffre perché, nei casi peggiori, limita lo svolgimento delle normali attività quotidiane con ricadute anche a livello psicologico, come ansia o depressione.
Al momento, non sono note le cause che determinano il manifestarsi di questo disturbo, ma è possibile che il senso di spossatezza sia una conseguenza dei problemi respiratori associati all’infezione da Sars-Cov-2.
Rinunciare per lunghi periodi all’esercizio fisico in generale non è una buona idea ma, nel caso del long COVID, fare sport quando i sintomi sono ancora presenti rischia di essere controproducente e peggiorare la stanchezza.
È quindi importante riprendere l’esercizio in modo graduale, senza sforzarsi troppo e seguendo i consigli del proprio medico e di un trainer professionista.
Parlando di attività fisica in senso lato e facendo riferimento anche ai compiti della vita quotidiana, come per esempio pulire casa o cucinare, alcuni esperti suggeriscono, per chi soffre da fatica cronica da long COVID, un approccio basato sul metodo delle 3P:
- Pause: quando ci si sente stanchi, è importante fermarsi a riprendere fiato ed energia. Sforzare troppo il proprio fisico può essere controproducente.
- Prioritizzazione, ovvero fare una lista delle attività da svolgere, ordinandole in base all’importanza e rinunciando a fare le attività con priorità minore.
- Programmazione, cioè cercare quanto più possibile di decidere in anticipo quali attività svolgere e quando, in modo da poter organizzare la giornata calibrando le proprie energie in base ai compiti da portare a termine.
Dopo la guarigione dal COVID-19 è importante monitorare con attenzione il proprio stato di salute.
In caso di sintomi come stanchezza prolungata o altri disturbi associati con la presenza di long COVID, per prima cosa è necessario consultare il proprio medico e valutare insieme quale strategia diagnostica e terapeutica applicare alle esigenze individuali di ognuno.
Fonti:
- Greenhalgh T, et al. Management of post-acute covid-19 in primary care BMJ. 2020 Aug 11;370:m3026.
- Lopez-Leon S, et al. More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. medRxiv. 2021 Jan 30;2021.01.27.21250617.
- Sandler CX, et al. Long COVID and Post-infective Fatigue Syndrome: A Review. Open Forum Infect Dis. 2021 Sep 9;8(10):ofab440.
I (brutti) ricordi
che il COVID può lasciare
al cuore e al metabolismo

Che l’infezione da Sars-Cov-2 sia associata all’aumento di problematiche cardiovascolari, non è una novità.
Il COVID-19 nella fase acuta dell’infezione, infatti, è correlato a un rischio di contrarre disturbi cardiovascolari, come infarto miocardico, insufficienza cardiaca o ictus, quattro volte superiore rispetto alle persone sane.
Quello che sta emergendo è che il rischio cardiovascolare si mantiene alto anche dopo la guarigione.
Si parla infatti di long COVID, ovvero di una serie molto variegata di disturbi e problematiche, tra cui fatica cronica, difficoltà cognitive e/o respiratorie, che persistono anche diverso tempo dopo essere guariti dall’infezione, da 4 settimane a 1 anno.
Alcuni studi sull’argomento mostrano che il cuore non è esente da conseguenze in chi è stato colpito da COVID-19: l’infezione espone a un rischio del 50% superiore di avere disturbi cardiovascolari, rispetto a chi non è stato infettato dal virus. Tale rischio si mantiene elevato fino a un anno dopo la guarigione.
Secondo altri studi, la tachicardia, ovvero l’aumento della frequenza cardiaca, si manifesta con maggiore frequenza in persone con i sintomi del long COVID.
Non è ancora chiaro il meccanismo con cui l’infezione da Sars-Cov-2 determini questi disturbi: probabilmente si tratta da una parte dell’azione diretta del virus sugli organi del sistema cardiovascolare e dall’altra da una serie di alterazioni provocate all’organismo nel suo insieme.
Un altro ricordo decisamente brutto che può essere associato al COVID-19 sono alterazioni del metabolismo e del controllo glicemico. In particolare, l’insorgenza di diabete sembra aumentare nei soggetti colpiti dal virus, anche in coloro che sono guariti dall’infezione. Alcuni specialisti parlano addirittura di una nuova epidemia di diabete, visto l’aumento di casi riscontrati tra coloro che soffrono di long COVID.
Sembra che il virus Sars-Cov-2 sia in grado di provocare alterazioni nella gestione della glicemia, ovvero del contenuto di zuccheri presenti nel sangue.
In molti casi, infatti, le persone affette da COVID-19 mostrano un elevato tasso glicemico.
Anche in questo caso, come per le malattie cardiovascolari, non siamo a conoscenza del meccanismo preciso con cui il virus determina il manifestarsi del diabete.
I ricercatori suppongono che ci siano diverse alterazioni a livello metabolico e cellulare che, sommate tra loro, provocano questo disturbo.
Inoltre, non è ancora chiaro se il diabete di nuova diagnosi che si manifesta in seguito all’infezione da Sars-Cov-2 sia permanente o transitorio, perché attualmente non sono disponibili studi a lungo termine su questa problematica.
Alla luce di quanto abbiamo visto, è fondamentale tenere sotto controllo la propria salute, anche dopo essere guariti dal COVID-19. In caso di sintomi che possono essere associati alla presenza di long COVID, la scelta da fare è quella di recarsi dal proprio medico per verificare insieme la situazione.
In questo modo sarà possibile svolgere tutti i necessari accertamenti, per proteggere il proprio benessere e quello delle proprie famiglie.
Fonti:
- Wan EYF, et al. Association of COVID-19 with short- and long-term risk of cardiovascular disease and mortality: a prospective cohort in UK Biobank. Cardiovasc Res . 2023 Jan 19;cvac195.
- Al-Aly Z, et al. High-dimensional characterization of post-acute sequelae of COVID-19. Nature. 2021 Jun;594(7862):259-264.
- Espinosa-Gonzalez AB, et al. Orthostatic tachycardia after covid-19. BMJ. 2023 Feb 24;380:e073488.
- Khunti K, et al. COVID-19, Hyperglycemia, and New-Onset Diabetes.Diabetes Care. 2021 Dec;44(12):2645-2655.
Cosa significa soffrire
di long COVID

Secondo le principali istituzioni sanitarie, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si parla di long COVID quando segni (alterazioni rilevabili con un esame medico) e sintomi causati dall’infezione da SARS-CoV-2 continuano o si sviluppano dopo 4 settimane dall’infezione acuta.
Se da una parte la patologia acuta da COVID-19 risulta ormai ben caratterizzata, ad oggi sono ancora in corso diversi studi per fare chiarezza riguardo al long COVID.
L’OMS spiega che sono oltre 200 i sintomi descritti per questa patologia, ma non tutti si manifestano con lo stesso grado di frequenza o gravità.
Il rischio di sviluppare disturbi legati al long COVID e il peso di questa condizione sono alti anche in pazienti che non hanno avuto una malattia acuta tanto grave da richiedere il ricovero ospedaliero. Il rischio di avere il long COVID, tuttavia, aumenta con l’aumentare della gravità dei sintomi osservati durante la fase acuta.
Secondo alcuni studi, è la stanchezza o spossatezza il sintomo più frequente lamentato da chi soffre di long COVID. Il livello di spossatezza può essere tale da non permettere al soggetto di uscire di casa anche per periodi molto lunghi.
Gli altri disturbi maggiormente diffusi sono:
- difficoltà respiratorie
- mal di testa
- dolore
- tosse
- perdita o riduzione del senso dell’olfatto
- affaticamento mentale e disturbi dell’attenzione
- perdita dei capelli.
Esistono purtroppo anche sintomi più gravi, associati al long COVID, per fortuna meno frequenti.
Tra questi, vi sono i disturbi cardiovascolari, come insufficienza cardiaca, ictus, infarto, arresto cardiaco e altre patologie.
Le persone affette da long COVID hanno un rischio del 50% superiore rispetto agli individui sani di sviluppare problemi a livello dell’apparato cardiovascolare.
Alcuni studi clinici mostrano inoltre che questi disturbi possono manifestarsi anche in individui sani, tra cui per esempio atleti professionisti, o in persone che hanno manifestato un’infezione acuta da COVID-19 con sintomi lievi.
Infine, altri sintomi gravi e potenzialmente letali legati alla presenza di long COVID sono quelli a carico del sistema renale e del sistema endocrino.
Alcuni studi mostrano infatti che chi soffre di long COVID è esposto a un rischio superiore di sviluppare insufficienza renale o diabete. Rischio che aumenta tanto più l’infezione acuta è stata grave.
Tutte queste evidenze mostrano che è fondamentale tenere sotto controllo le proprie condizioni di salute anche dopo essere guariti dalla sindrome acuta causata dall’infezione con il virus Cov-Sars-2, per almeno un anno.
Un’attenzione particolare deve essere riservata a tutto quello che riguarda l’apparato cardiovascolare e renale e il controllo glicemico.
In caso di sintomi che possono essere associati alla presenza di long COVID, la prima e più importante mossa da fare è recarsi subito dal proprio medico curante, per una prima valutazione della situazione. In questo modo, sarà possibile decidere quale strada seguire e proteggere la propria salute e quella dei propri cari.
Fonti:
- WHO. A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. October 2021
- Al-Aly Z, et al. High-dimensional characterization of post-acute sequelae of COVID-19. Nature. 2021 Jun;594(7862):259-264.
- Lopez-Leon S, et al. More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis.medRxiv. 2021 Jan 30;2021.01.27.21250617.
- Wan EYF, et al. Association of COVID-19 with short- and long-term risk of cardiovascular disease and mortality: a prospective cohort in UK Biobank. Cardiovasc Res . 2023 Jan 19;cvac195.
- Bowe B, et al. Kidney Outcomes in Long COVID. J Am Soc Nephrol. 2021 Nov;32(11):2851-2862.
Long COVID:
cos'è e perché
devi conoscerlo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne soffre dal 10% al 20% delle persone colpite da infezione da COVID-19: tra il 2020 e il 2021, si parla di circa 17 milioni di persone.
È il long COVID, che l’OMS e le principali istituzioni sanitarie mondiali definiscono come una condizione caratterizzata dalla presenza di segni e sintomi causati dall’infezione da SARS-CoV-2 che continuano o si sviluppano dopo 4 settimane dall’infezione acuta.
In particolare, il long COVID può essere distinto in due tipologie:
- una malattia da COVID-19 persistente, quando i disturbi si protraggono oltre il periodo dell’infezione acuta (4-12 settimane dopo)
- malattia da post-COVID-19, con disturbi che
- sono emersi durante o dopo un’infezione da COVID-19
- si protraggono per più di 12 settimane dopo l’evento acuto
- non sono spiegabili con diagnosi alternative.
Più di 100 sintomi sono stati descritti per il long COVID; tra i più frequenti ci sono:
- spossatezza
- fiato corto
- disturbi cognitivi.
In generale, si tratta di disturbi che possono manifestarsi durante l’infezione acuta da COVID, oppure diverse settimane dopo. L’andamento dei sintomi spesso è fluttuante: compaiono e vanno incontro ad apparente risoluzione, per poi ripresentarsi a distanza di tempo. Il primo a descrivere questa condizione è stato un infettivologo inglese che l’ha sperimentata di persona, commentando che era “come sentirsi sulle montagne russe”.
Nonostante quello che si potrebbe pensare, il long COVID può colpire tutte le persone precedentemente affette da COVID-19, indipendentemente dalla gravità della malattia in fase acuta.
Diversi studi sono stati realizzati con lo scopo di valutare la presenza di sintomi nelle persone affette da long COVID e l’impatto che questi possono avere sulla vita individuale e sulla società.
Giorni di lavoro persi, visite mediche e in alcuni casi accessi in ospedale rappresentano un fardello considerevole, sia a livello sociale che sanitario. Senza contare poi l’impatto psicologico e sulla vita familiare.
Che cosa si può fare, per combattere lo sviluppo del long COVID, con tutte le problematiche connesse?
Uno studio svolto nel Regno Unito su quasi 30.000 persone ha mostrato che la probabilità di andare incontro a questa patologia si riduce in seguito alla vaccinazione contro il COVID-19. Si parla di una riduzione consistente del rischio, dopo la somministrazione della seconda dose.
Sono necessari ulteriori studi per chiarire meglio l’effetto della campagna vaccinale, ma alcuni dati raccolti finora sostengono l’ipotesi che il vaccino possa rappresentare un’arma utile contro la comparsa di long COVID.
Per sostenere i cittadini affetti colpiti da COVID-19 e che potrebbero sviluppare, o hanno già accusato, i sintomi da long COVID possono inoltre essere messe in atto altre azioni.
Un esempio virtuoso è la Germania, che ha recentemente varato un vero e proprio piano d’azione, con l’obiettivo finale di migliorare l'assistenza ai pazienti che apparentemente sono guariti dall'infezione da Sars-CoV-2, ma ancora ne portano i segni. Il piano prevede l'apertura di uno sportello telefonico per assistere i pazienti e un programma di investimenti mirato a finanziare gli studi sulla sindrome post-virus.
Una task force di ricercatori della KU Leuven, un'università belga, ha redatto nel 2022 delle linee guida per aiutare gli operatori sanitari a trattare i pazienti con long COVID. Nel luglio 2022, è stato lanciato un progetto pilota di percorso assistenziale per i pazienti con sintomi presenti da 12 settimane o più dopo la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 o dopo l'insorgenza dei primi disturbi.
Le istituzioni sanitarie di tutto il mondo stanno lavorando per garantire la migliore assistenza possibile a chi soffre di long COVID, con la speranza di ridurre il peso sociale ed economico di questa condizione.
In caso di sintomi associati all’infezione da Sars-Cov-2, sia acuti, che persistenti, la prima cosa da fare è consultare il proprio medico di base, che saprà consigliare la strategia più adatta alle esigenze di ogni singolo paziente.
Fonti:
- ISS. Buone pratiche cliniche per la gestione e presa in carico delle persone con long-co
- WHO. A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. October 2021
- Garner P. For 7 weeks I have been through a roller coaster of ill health, extreme emotions, and utter exhaustion [https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/05/paul-garner-people-who-have-a-more-protracted-illness-need-help-to-understand-and-cope-with-the-constantly-shifting-bizarre-symptoms/] 2020.
- Mizrahi B, et al. Long covid outcomes at one year after mild SARS-CoV-2 infection: nationwide cohort study. BMJ. 2023 Jan 11;380:e072529.
- Perlis HR, et al. Association of Post-COVID-19 Condition Symptoms and Employment Status. JAMA Netw Open. 2023 Feb 1;6(2):e2256152.
- Ayoubkhani D, et al. Trajectory of long covid symptoms after covid-19 vaccination: community based cohort study BMJ. 2022 May 18;377:e069676.
- Doctor 33.it Long Covid, la Germania vara un piano contro la sindrome. Ecco cosa prevede. Gennaio 2023
- Quotidiano Sanità. Long Covid. In Europa colpite 17 milioni di persone. Dal Belgio linee guida per aiutare gli operatori sanitari a trattare i pazienti. Marzo 2023
Ecco cosa fare
e come distinguerli.

Anche se vi siete sottoposti al vaccino anti Covid-19 esiste la possibilità che possiate contrarre l’infezione da questo virus.
Ma questo non significa che il vaccino sia inefficace. Il ruolo della vaccinazione è quello di “insegnare” al nostro organismo a riconoscere rapidamente il virus e a mettere in atto i meccanismi di difesa indispensabili per combatterlo. Nel caso dei vaccini anti Covid-19, questo significa che rimane una probabilità di contrarre la malattia, ma in forma decisamente più lieve. Quindi, è possibile sviluppare alcuni dei sintomi minori del Covid-19, come febbre, dolore alle ossa o tosse, ma la buona notizia è che il rischio di essere ricoverati o di finire in terapia intensiva per le persone vaccinate è molto più basso rispetto a quello a cui andrebbero incontro se entrassero in contatto con il virus senza prima aver ricevuto il vaccino.
Il rischio si abbassa ancora di più dopo aver effettuato la dose booster (la famosa “terza dose”), e la protezione dei vaccini rimane anche con le varianti più recenti, inclusa la Omicron.
Ma quali sono i sintomi a cui prestare attenzione? E come fare a capire se si tratta davvero di Covid-19, oppure di altri virus tipici del periodo invernale, come quello dell’influenza?
L’infezione da Covid-19 provoca la comparsa di sintomi che, in molti casi, possono essere simili a quelli dell’influenza. Entrambi i virus, infatti, possono generare:
- febbre e brividi;
- tosse
- fiato corto o difficoltà respiratorie;
- spossatezza
- mal di gola;
- naso che cola;
- dolori muscolari;
- mal di testa;
- vomito e/o diarrea;
- alterazioni nel senso del gusto e dell’olfatto, anche se quest’ultimo sintomo si presenta con più frequenza
in persone colpite dal Covid-19.
Le principali differenze tra infezione da Covid-19 e influenza sono elencate qui sotto:
Covid-19:
- i sintomi compaiono: da 2 a 14 giorni dopo l’infezione;
- si possono contagiare altre persone: da 2 giorni prima della comparsa dei sintomi fino a circa 10 giorni dopo (nel caso di pazienti gravi e/o ricoverati in ospedale, la contagiosità può durare fino a 20 giorni e oltre);
- complicazioni: più gravi rispetto all’influenza, possono verificarsi anche in persone non fragili.
Influenza:
- i sintomi compaiono: da 1 a 4 giorni dopo l’infezione;
- si possono contagiare altre persone: da 1 giorno prima della comparsa dei sintomi, fino a circa 7 giorni;
- complicazioni: meno gravi rispetto al Covid-19, generalmente si verificano in persone fragili come anziani o immunocompromessi.
Un’altra differenza tra Covid-19 e influenza è che il primo si diffonde molto più rapidamente.
Anche se tra i due virus esistono delle differenze osservabili in termini di sintomi, l’unico modo sicuro per distinguerli è sottoporvi a un tampone naso-faringeo molecolare. Il vaccino antinfluenzale aiuta nella diagnosi differenziale: chi, vaccinato contro l’influenza, sviluppa i sintomi sopra descritti, ha con alta probabilità Covid-19, ma è solo con un tampone che si avrà la risposta definitiva.
Ricordatevi che è fondamentale rivolgervi sempre prima al vostro medico ed evitare il fai-da-te, che in questi casi può portare a conseguenze molto gravi.
Se il tampone molecolare conferma la presenza di infezione da Covid-19, il vostro medico vi indicherà la strada terapeutica da seguire. Fortunatamente, se siete vaccinati la malattia sarà molto più facilmente gestibile rispetto a quanto accade nelle persone che non si sono sottoposte alla vaccinazione.
Se il tampone molecolare risulta negativo, è molto probabile che i vostri sintomi siano dovuti a influenza o altri virus tipici della stagione fredda.
In ogni caso, assicuratevi di avere sempre a disposizione farmaci per la gestione dei sintomi più frequenti, come febbre, mal di testa, dolori muscolari, tosse (e seguite le indicazioni del medico su come usarli).
Che si tratti di influenza o di Covid-19, anche il riposo e l’idratazione regolare sono di aiuto.
Con un’ultima precisazione importante: anche se l’influenza può sembrarvi una malattia “banale”, ricordate di non prenderla sottogamba e di seguire i consigli del vostro medico o farmacista di fiducia, che vi indicheranno il modo più efficace di gestire i sintomi e aiutarvi a superare il malessere.
Fonti:
- https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_444_0_alleg.pdf
- https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
- https://www.medicalnewstoday.com/articles/coronavirus-vs-flu
- https://www.humanitas.it/news/chi-e-vaccinato-puo-ammalarsi-di-covid-19/
- https://www.humanitas-sanpiox.it/news/covid-19-e-vaccino-perche-si-contrae-linfezione/
Pandemie
del passato
mascherine e distanziamento però funzionano
ancora. Capiamo con Sally il perché.

Da millenni gli esseri umani convivono con virus e batteri, e non sempre i rapporti sono stati buoni.
Vi sono stati casi in cui epidemie hanno assunto proporzioni continentali o globali, lasciando un segno indelebile anche nell’arte (pensate al Decamerone del Boccaccio, ai capitoli che il Manzoni dedica alla peste di Milano nei Promessi Sposi o alle raffigurazioni di San Rocco, santo protettore degli appestati, frequenti nelle nostre Chiese), nella lingua e nelle tradizioni.
È il caso della peste, che nel XIV secolo sconvolse l’Europa intera e lo fece a più riprese nei secoli successivi.
Fu proprio durante questo periodo che, per la prima volta, vennero coniati termini che ancora oggi conosciamo e utilizziamo:
- Quarantena: termine di origine veneziana per indicare il periodo di isolamento (di 40 giorni) che marinai o passeggeri affetti da malattie dovevano trascorrere, prima di poter entrare in città dopo un lungo viaggio, specie se provenienti da regioni dove erano in corso epidemie;
- Lazzaretto: il periodo di quarantena in Laguna veniva trascorso sull’isola di San Lazzaro, da cui ha avuto origine il termine; successivamente, con lazzaretto si indicava un ospedale temporaneo in cui venivano ricoverati i malati sia per curarli, sia per tenerli separati dal resto della popolazione.
Anche le mascherine hanno una lunga storia. In origine erano rigide e caratterizzate dalla presenza di un naso molto lungo, dove venivano riposte erbe ed essenze dal forte odore, che si pensava uccidessero gli agenti infettivi; questa particolare maschera è entrata a far parte dei tradizionali costumi legati al carnevale veneziano, ed è nota appunto con il nome di Dottore della Peste, ma la sua funzione iniziale era la medesima di quelle che usiamo noi oggi, e cioè impedire un contagio.
Le epidemie di peste hanno mietuto vittime in diversi periodi storici e solo negli anni Cinquanta vennero sintetizzati per la prima volta antibiotici in grado di aggredire il batterio responsabile di questa patologia. Fu quindi lo sviluppo di farmaci efficaci a permettere di archiviare le epidemie di peste, che ora si manifesta solo come casi di infezione isolata.
All’inizio del ‘900, invece, fu l’influenza a diffondersi con insolita violenza, causando la pandemia nota con il nome di Influenza Spagnola. Rispetto alle altre influenze, la Spagnola era caratterizzata da una notevole mortalità. Questo era probabilmente dovuto anche alla sua esplosione in contemporanea alle ultime fasi della Grande Guerra, con ampie fette della popolazione allo stremo per le privazioni provocate dal conflitto.
Il nome lo prese dalla nazione dove per prima ne venne segnalata la presenza, anche se con tutta probabilità era già diffusa in altre nazioni europee. Ma la Spagna in quegli anni non era in guerra, e la notizia di un’epidemia di influenza associata ad anomala mortalità poteva essere diffusa con più libertà.
Armi importanti per combattere l’epidemia di Spagnola furono i farmaci antipiretici, le cui prime molecole erano state sintetizzate alcuni decenni prima (fenacetina, sintetizzata nel 1889 e oggi in disuso; acido acetilsalicilico, sintetizzato nel 1899 e ancora oggi impiegato). Gli antipiretici permettevano di abbassare la febbre, fino a quel momento un sintomo problematico da gestire.
Nella storia, le epidemie compaiono e si spengono, per poi ricomparire a distanza di anni o secoli. In passato, quando non esistevano i vaccini, la ciclicità con cui si presentavano epidemie come quelle di peste era dovuta alla perdita di immunità nella popolazione (le nuove generazioni non avevano l’immunità che le vecchie generazioni avevano acquisito dall’epidemia precedente, e diventavano più suscettibili a un nuovo contagio). Oggigiorno, le nuove pandemie sono dovute in parte all’emergenza di nuovi virus, come il SARS-CoV-2, che generano malattie mai viste prima (Covid-19), e in parte alla formazione di varianti di virus già conosciuti, che ne aumentano l’aggressività, portando quindi a una ricomparsa di malattie che si credevano sconfitte.
In altri casi, patologie che si pensavano quasi scomparse, tornano a colpire, per un calo della copertura vaccinale, come nel caso del morbillo, per il quale si osservano focolai epidemici in diversi paesi occidentali.
Post covid
Sally ci aiuta a capire come anche l’attività
fisica è importante.

Anche dopo essere guariti dall’infezione da Covid-19, e cioè dopo che i tamponi hanno dato esito negativo, in alcuni casi è ancora possibile che permangano alcuni sintomi. Questi potrebbero durare settimane o perfino mesi, nel caso siate ricovero in ospedale.
Come gestirli? Fate sempre riferimento al vostro medico, ma qui potete trovare alcuni suggerimenti utili:
Fiato corto.
Si tratta di un sintomo comune e ci sono alcuni piccoli accorgimenti per ridurre il disagio.
Tutte le volte che è possibile, assumi una posizione che ti faciliti la respirazione:
- siediti in modo tranquillo, cercando di rilassare i muscoli;
- stai in piedi e chinati in avanti, poggiando le mani su una superficie come un davanzale o un tavolo;
- stai in piedi appoggiando la schiena contro una superficie solida, come per esempio una parete;
- siediti piegandoti leggermente in avanti o appoggiandoti su un ripiano come una scrivania;
- sdraiati su un fianco, appoggiando testa e spalle su più cuscini, così da tenere la schiena inclinata.
Cerca di respirare lentamente, inspirando con il naso ed espirando con la bocca. Cerca di tenere con la respirazione un rapporto 1:2, ovvero espira per il doppio del tempo che dedichi all’inspirazione.
Per esercitarti a tenere questo rapporto, mettiti in una posizione comoda e fissa un oggetto rettangolare (una finestra, il televisore). Percorri il perimetro con gli occhi: inspira lungo il lato corto ed espira lungo il lato lungo.
Ricordati di arieggiare la stanza in cui ti trovi, per favorire il ricambio d’aria.
Nel caso in cui la mancanza di respiro peggiori, rivolgiti al medico.
Tosse.
In caso di tosse secca, ecco alcuni consigli che ti possono essere utili per ridurre il fastidio:
- idratati, bevendo piccoli sorsi di acqua o succhi di frutta; da evitare l’alcool;
- bevande calde, come the o infusi, accompagnati da qualche goccia di miele o limone, per ridurre il fastidio alla gola;
- usa un aerosol per inalare vapore. Va bene anche mettere a bollire una pentola di acqua sul fuoco e usare un panno per coprirti la testa, mentre respiri i vapori caldi. Abbi cura di mantenere un buon grado di umidità nella stanza dove dormi, ad esempio con un umidificatore;
Nel caso di tosse grassa, può essere utile anche:
- tenerti in movimento, per favorire lo spostamento del catarro, in modo che tu possa espellerlo con la tosse;
- quando ti sdrai, scegli una posizione sul fianco.
Spossatezza e debolezza muscolare.
Dopo un ricovero per Covid-19 oppure, in generale, dopo essere guariti da questa malattia, potreste provare un profondo senso di spossatezza.
Potrebbe essere faticoso muoversi per la casa o gestire le solite attività quotidiane. È importante capire quali sono i tuoi livelli di energia e adattarti in modo da non sforzarti troppo.
Un suggerimento? Usa le 4 P:
- Programmazione/planning
Organizzati e decidi in anticipo le cose da fare durante la giornata, così avrai il tempo di svolgere ogni compito con calma, senza affrettarti. Ricordati che la fretta ti fa consumare più energia. - (Tieni il) Passo
Scegli il ritmo giusto che ti permette di non sprecare energia e di non stancarti in modo eccessivo. - Posizione
Quando devi svolgere un compito, è importante che tu abbia tutto a portata di mano: in questo modo, eviterai di perdere tempo, e soprattutto energia, nel procurarti quello che ti serve. Prima di cominciare a fare qualsiasi cosa, quindi, raduna tutto l’occorrente. - Priorità
Questo è forse il consiglio più difficile da seguire. Quando hai poca energia a disposizione, la cosa più importante è analizzare in modo critico i tuoi impegni lavorativi, sociali e familiari, e decidere quali sono le tue priorità. Quali compiti non possono essere rimandati e quali, invece, possono aspettare o, anche, essere eliminati dalla tua lista di cose da fare?
Mal di testa, dolori muscolari o articolari.
Il dolore può essere un altro sintomo fastidioso che permane dopo la risoluzione dell’infezione da Coronavirus. La buona notizia è che il dolore, sia alla testa che ai muscoli o alle articolazioni, generalmente passano al più dopo qualche settimana. Bisogna armarsi di pazienza e, quando diventano più intensi, ricorrere a un farmaco analgesico.
A prescindere dalla persistenza di alcuni sintomi, dopo un’infezione respiratoria, specie se debilitante, è necessario seguire un’alimentazione che supporti il nostro corpo a rigenerarsi. Quindi, a meno che non esistano controindicazioni specifiche, è utile includere un adeguato quantitativo di proteine nella dieta, che contengono i “materiali da costruzione” che aiutano il nostro corpo ricostruire i tessuti deperiti. A queste vanno aggiunte vitamine e minerali, e una quantità adeguata di fluidi durante tutta la giornata, per evitare il rischio di disidratarsi.
Una dieta per la convalescenza dopo un’infezione respiratoria (Covid-19 o influenza), quindi, deve comprendere, ogni giorno:
- 3 porzioni di proteine (per esempio, fagioli, legumi, pesce, uova, carne – cercando di contenere al minimo le carni rosse e processate);
- 1 bicchiere di latte o yogurt;
- 5 porzioni di frutta e verdura, cercando di variare ogni giorno.
La ripresa dell’attività fisica.
Riprendere l’attività fisica dopo un’infezione respiratoria è utile anche per stimolare il sistema immunitario a sviluppare anticorpi contro il virus che ha provocato l’infezione. Tuttavia, è importante non strafare e riprendere quando i sintomi si sono completamente risolti, altrimenti il fisico, ancora debilitato, non solo non beneficerebbe dell’attività fisica, ma avrebbe una maggiore probabilità di infortunarsi.
Come regola generale, chiedi consiglio al tuo medico, che conosce la tua situazione specifica e saprà consigliarti sul momento l’attività più adatta alla ripresa.
Ecco alcuni piccoli consigli per la ripresa dell’attività fisica dopo un episodio di Covid-19:
- Se durante l’infezione hai avuto bisogno di ossigeno o hai avuto complicanze serie, come una polmonite, non riprendere a fare esercizio fisico senza aver prima sentito il medico.
- In tutti gli altri casi, se durante l’infezione hai avuto mal di gola intenso, dolori muscolari, fiato corto, spossatezza, febbre, tosse o dolore al petto, non intraprendere alcuna attività se non sono passate almeno 2-3 settimane dalla completa risoluzione dei sintomi.
- Prima di intraprendere un’attività sportiva vera e propria, inizia con una settimana di esercizi di mobilizzazione e di rinforzo della muscolatura. Ti eviteranno spiacevoli infortuni come contusioni o distorsioni.
- Aver fatto il Covid-19 non significa avere necessariamente una buona immunità! Esegui l’attività fisica nel rispetto di tutte le norme di contenimento della pandemia, per la tutela della salute di tutti: degli altri e tua.