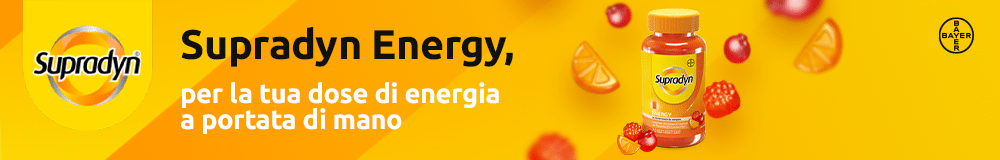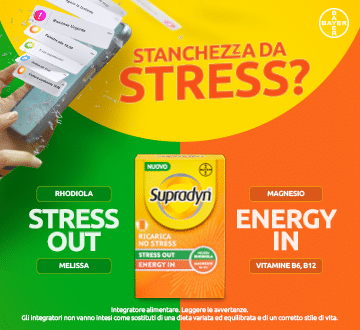Io & Sally: una stagione di consigli.
Se prima eravamo abituati a pensare a influenza e raffreddore come fastidiosi contrattempi, il COVID-19 ci ha fatto capire l’importanza di gestire adeguatamente queste infezioni.
Questo, il punto di partenza di #UnaStagioneDiConsigli: iniziativa Bayer con lo scopo di informare in modo semplice e chiaro sui temi legati all’attualità e alle infezioni respiratorie.