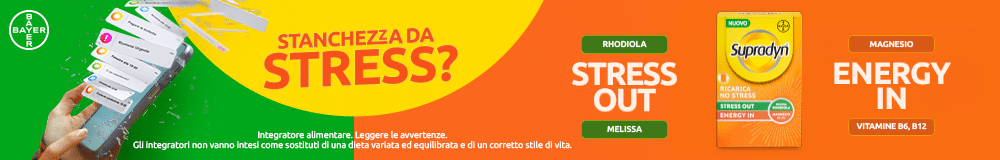- Che cosa sono
- Aritmie ipercinetiche
- Aritmie ipocinetiche
- Sintomi
- Cause
- Terapie
- Prevenzione e diagnosi
Che cosa sono
In medicina, sono definite aritmie cardiache le alterazioni del battito del cuore che possono riguardare la frequenza o il ritmo. Si verificano quando il cuore batte troppo veloce, troppo lento oppure con un ritmo irregolare.
Quando il battito cardiaco è troppo veloce, cioè superiore a 100 battiti al minuto, si parla di tachicardia, quando è troppo lento, ossia inferiore a 60 battiti al minuto, si definisce bradicardia.
Esistono diversi tipi di aritmia, a seconda della sede coinvolta e del tipo di anomalia elettrica.
Aritmie ipercinetiche
Un'aritmia di questo tipo può essere di tipo sopraventricolare o ventricolare.
Aritmie sopraventricolari
- Extrasistoli. Sono caratterizzate da una contrazione anticipata del muscolo cardiaco. Il sintomo tipico è la sensazione del “battito che manca” o dello “sfarfallio ”, con brevi episodi di palpitazioni. Di solito non sono pericolose e sono frequenti le forme asintomatiche.
- Fibrillazione atriale (AF). È una tachiaritmia molto comune, ne soffre oltre il 5 per cento della popolazione al disopra dei 70 anni e il 10 per cento degli over 80. Consiste in una contrazione molto rapida (fibrillazione) delle pareti atriali, con una frequenza variabile nella trasmissione dell’impulso e, di conseguenza, irregolarità del battito cardiaco. Si divide in parossistica (a regressione spontanea), persistente (quando il ripristino del ritmo sinusale si ottiene con farmaci o cardioversione elettrica), permanente (quando è ormai resistente a tutte le terapie ed è diventata cronica). La principale complicazione della fibrillazione atriale è l’ictus, che può insorgere con pari frequenza anche nella fibrillazione parossistica, per questo un paziente che soffre di AF deve assumere anticoagulanti. Questo tipo di aritmia può aumentare anche il rischio di scompenso cardiaco.
- Flutter atriale. È simile alla fibrillazione atriale, ma in questo caso il segnale, invece di diffondersi in modo caotico attraverso gli atri, si muove come se fosse un’onda circolare in maniera veloce e regolare. Fra le tachiaritmie, è una forma meno frequente della precedente, anche se a volte evolve in fibrillazione atriale. Dà gli stessi sintomi e le stesse complicazioni.
- Tachicardia reciprocante nodale (TRN). A causarla è una via lenta di conduzione a livello del nodo atrioventricolare: inizia e finisce all’improvviso ed è di durata variabile. Di solito non è pericolosa, è tipica dell’età giovanile, è diffusa soprattutto tra le ragazze.
- Sindrome di Wolff-Parkinson-White. Il segnale elettrico viaggia dagli atri ai ventricoli seguendo un percorso alternativo a quello fisiologico. È una delle forme di aritmia più pericolose.
Aritmie ventricolari
- Extrasistoli ventricolari. Aritmie che coinvolgono i ventricoli: si assiste a una contrazione ventricolare prematura. Quando sono singole contrazioni, o in coppia, e non sono associate ad altre cardiopatie, hanno la stessa rilevanza delle extrasistoli sopraventricolari.
- Tachicardia ventricolare. Consiste in un battito rapido, ma regolare, dei ventricoli che può durare da pochi secondi ad alcune ore. Se è un episodio breve, non comporta problemi. Se invece è prolungato nel tempo può essere pericoloso. In alcuni casi evolve in forme più gravi di aritmia, come per esempio la fibrillazione ventricolare.
- Fibrillazione ventricolare. Si verifica quando segnali elettrici disorganizzati spingono i ventricoli a fremere e tremare. E di conseguenza non riescono più a pompare il sangue nel corpo. Quando succede, in genere, dopo pochi secondi si perde conoscenza. Se non si interviene tempestivamente con shock elettrico al cuore o defibrillazione, il decesso sopravviene entro pochi minuti.
Aritmie ipocinetiche
- Malattia del nodo del seno. Rientra fra le bradiaritmie e in questo caso, la frequenza del battito è più lenta del normale. Quando è troppo lenta, il cervello può non ricevere più una quantità sufficiente di sangue. I sintomi tipici sono dispnea e astenia per minimi sforzi.
- Blocchi atrioventricolari. Si suddividono in blocchi di primo, secondo e terzo grado a seconda della gravità e del tipo di blocco dell’impulso. Nei casi più gravi si possono verificare sincope e arresto cardiaco.
Sintomi
In molti casi, le aritmie non danno segni o sintomi della loro presenza. In tutte le altre circostanze si possono manifestare:
- palpitazioni
- battito lento
- battito irregolare
- battito mancante
- sfarfallio
Altri sintomi possono essere:
- ansia
- debolezza
- vertigini
- stordimento
- svenimento
- sudorazione eccessiva
- respiro corto
- dolore toracico
Cause
A causare le aritmie, in genere, è un’attività non fisiologica da parte delle cellule cardiache specializzate nel produrre i segnali elettrici.
In altri casi è il segnale che non “viaggia” come dovrebbe attraverso il cuore.
Sono stati individuati anche alcuni fattori di rischio che favoriscono l’insorgenza di aritmia:
- fumo di sigaretta
- abuso di alcool
- uso di droghe quali cocaina o amfetamine
- assunzione di caffeina in quantità eccessiva
- assunzione di alcuni farmaci
- disturbi digestivi
- BPCO.
Anche un forte stress emozionale o un attacco di collera possono indurre un’accelerazione del battito cardiaco, un aumento dei valori pressori e il rilascio degli ormoni dello stress. E di conseguenza innescare un’aritmia.
Le patologie che possono portare, tra le loro conseguenze, a un’aritmia sono:
- infarto cardiaco
- ipertensione
- patologie coronariche
- disfunzioni tiroidee
- patologie reumatiche del cuore.
In alcune forme di aritmia c’è una dimostrata componente genetica.
Terapie
Non tutte le aritmie richiedono un trattamento farmacologico. Qualora il cardiologo lo ritenga opportuno, i farmaci più utilizzati per la cura delle aritmie sono:
| Antiaritmici | Sono usati per accelerare o rallentare il battito cardiaco e per convertire il ritmo cardiaco, da anormale, in stabile e normale. I farmaci che rallentano la frequenza cardiaca sono i beta-bloccanti e alcuni calcio-antagonisti. Per controllare il ritmo cardiaco si usano invece amiodarone, sotalolo, flecainide, propafenone. Vanno dosati da uno specialista aritmologo |
| Anticoagulanti | Nella fibrillazione atriale, se non ci sono controindicazioni, sono usati farmaci anticoagulanti, che servono a fluidificare il sangue e quindi a prevenire la formazione di coaguli sanguigni. |
Esistono anche trattamenti non farmacologici per alcune aritmie. Ecco le principali procedure chirurgiche, interventi comuni nei reparti di cardiologia di ogni ospedale.
| Pacemaker | È un piccolo strumento posizionato sotto la pelle del torace e serve a controllare, per mezzo di impulsi elettrici direzionati al cuore, il ritmo cardiaco. Si usa nelle aritmie ipocinetiche |
| Defibrillatore | Si utilizza in caso di aritmie ventricolari che non si risolvono soltanto con i farmaci. L’apparecchio, poco più grande di un pacemaker, riconosce e risolve le aritmie pericolose con uno shock elettrico. |
| Cardioversione elettrica | Fornisce al cuore una scarica elettrica ed è utile per fibrillazione o flutter atriale. |
| Ablazione transcatetere | Si tratta di una procedura che permette lo studio elettrofisiologico del cuore e la cura di diversi tipi di aritmie. L'intervento consiste nell'inserimento di un particolare elettrocatetere nella cavità cardiaca attraverso una vena femorale oppure una vena giugulare interna. In questo modo, è possibile valutare le caratteristiche elettriche del cuore ed erogare energia elettrica (radiofrequenza) dalla punta metallica del catetere. Il riscaldamento che ne consegue provoca delle piccolissime bruciature a livello dell’area di tessuto cardiaco coinvolta nella genesi dell’aritmia. |
Prevenzione e diagnosi
Alla luce delle molteplici cause che possono innescare un'alterazione del ritmo cardiaco, la prevenzione passa attraverso una serie di accorgimenti volti a tenere sotto controllo la salute del cuore.
L’alimentazione deve essere il più possibile equilibrata e varia. Va limitato in particolar modo il consumo di bevande alcoliche, dolci e cibi ad alto contenuto di grassi, soprattutto se di origine animale. È inoltre bene praticare in modo costante e regolare attività fisica, non fumare ed evitare il più possibile situazioni di stress.
In presenza di fattori di rischio congeniti o di malattie (ipertensione, cardiopatia ischemica) che possono facilitare l'insorgenza di aritmie cardiache, è essenziale il costante monitoraggio dell'attività cardiovascolare. Se la visita medica, comprensiva di anamnesi clinica e auscultazione del cuore, evidenzia problemi nel battito cardiaco possono essere prescritti ulteriori approfondimenti.
Gli esami del sangue possono aiutare a individuare possibili cause: alcune alterazioni degli elettroliti (soprattutto calcio, magnesio e potassio) possono dare origine ad aritmie. Lo stesso accade per la tiroide, dal cui mancato funzionamento può dipendere il ritmo cardiaco alterato.
Uno degli esami più diffusi e accurati dal punto di vista diagnostico è l'elettrocardiogramma (ECG). Il tracciato di un ECG è in grado di individuare con precisione un eventuale disturbo del ritmo cardiaco e permette ai medici di intervenire tempestivamente. Esistono diverse varianti di ECG, in base al tipo di aritmia sospettata e alle esigenze diagnostiche.
L'ECG secondo Holter permette di registrare l'attività cardiaca nell'arco di 24/48 ore, allo scopo di evidenziare aritmie passeggere o comunque di breve durata. Se sussiste la necessità di monitorare l'attività cardiaca per tempi più lunghi, è possibile ricorrere a un piccolo apparecchio impiantabile (loop recorder).
L'ECG sotto sforzo e la scintigrafia miocardica permettono di scoprire ischemie non rilevabili a riposo, che possono dare origine ad aritmie cardiache. Attraverso l'ecocardiogramma, infine, è possibile misurare il diametro delle camere cardiache e la loro funzionalità.
Alcuni pazienti vittime di sincope possono poi essere sottoposti al tilt test, che consiste nel monitoraggio della pressione e della frequenza cardiaca nel passaggio da una posizione verticale (ortostatica) a una orizzontale.