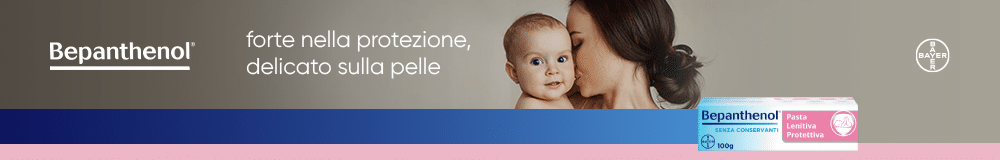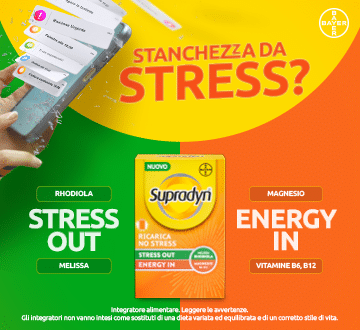- Come funzionano
- Perché sono essenziali
- Che cosa succede se lavorano troppo o troppo poco
- Diagnosi e trattamento delle disfunzioni paratiroidee
Sono piccole ghiandole situate nel collo che regolano i livelli di calcio nell'organismo.
Le paratiroidi sono quattro ghiandole endocrine, ovvero che secernono ormoni nel sangue.
Dal punto di vista funzionale sono del tutto indipendenti dalla tiroide, ma sono così chiamate per la loro stretta prossimità con quest’ultima; sono infatti posizionate in corrispondenza della parete posteriore della tiroide.
Le paratiroidi si distinguono in superiori e inferiori in base alla loro posizione.
Sono ghiandole estremamente piccole, ciascuna di dimensioni variabili tra quelle di un chicco di riso e quelle di una lenticchia e di peso compreso tra 10 e 60 milligrammi.
Come funzionano
Il compito principale delle paratiroidi è il controllo della distribuzione del calcio nell’organismo.
A regolare il funzionamento delle paratiroidi sono infatti le variazioni, anche minime, della concentrazione di calcio nel sangue (calcemia) rispetto ai suoi valori normali (compresi nel soggetto adulto tra 8,5 e 10,5 mg/dl).
Le cellule che compongono le paratiroidi sono dotate di specifici recettori che rilevano in modo continuo la calcemia e innescano l’attività delle ghiandole in caso di diminuzione dei livelli plasmatici di calcio o, viceversa, la inibiscono se questi salgono.
L’attivazione delle paratiroidi quando la calcemia è troppo bassa si traduce nella produzione dell’ormone paratiroideo (o paratormone) che, una volta immesso in circolo, raggiunge gli organi a livello dei quali agisce per riportare la quantità di calcio nel range di normalità.
Gli organi bersaglio del paratormone sono principalmente:
- lo scheletro, dove stimola il riassorbimento di tessuto osseo con conseguente liberazione del calcio in esso contenuto
- i reni, dove limita l’eliminazione di calcio con le urine (aumentando contemporaneamente quella del fosforo) e dove induce la conversione della vitamina D nella sua forma attiva, che ha l’effetto, a sua volta, di stimolare l’assorbimento del calcio assunto con gli alimenti a livello intestinale.
Perché sono essenziali
L’importanza del buon funzionamento delle paratiroidi risiede nel fatto che il calcio è coinvolto in una serie di processi fisiologici fondamentali:
- insieme con il fosforo, è l’elemento principale della componente minerale del tessuto osseo
- interviene nei meccanismi di conduzione degli impulsi elettrici lungo i nervi e in quelli di attivazione della contrazione dei muscoli
- funziona da regolatore delle reazioni che avvengono nelle cellule di molti organi e da modulatore dell’attività di vari enzimi.
Per questo motivo una disfunzione delle paratiroidi, che comporti una produzione eccessiva oppure insufficiente di paratormone, può avere molteplici effetti negativi, talora anche gravi.
Che cosa succede se lavorano troppo o troppo poco
L’alterazione più frequente dell’attività delle paratiroidi è il rilascio di una quantità eccessiva di paratormone, che è detta “iperparatiroidismo”.
Tale condizione può avere origine da un processo patologico a carico delle paratiroidi: il più comune è l’adenoma paratiroideo, un tumore benigno circoscritto che può svilupparsi in una o in più ghiandole.
Cause più rare sono l’iperplasia paratiroidea diffusa (con ingrossamento uniforme di tutte le ghiandole), il carcinoma paratiroideo e la neoplasia endocrina multipla (una sindrome ereditaria che interessa diverse ghiandole endocrine).
Quando l’eccessiva secrezione di paratormone deriva da una di queste malattie si parla di iperparatiroidismo “primitivo”, per distinguerlo dal tipo “secondario” che è determinato invece da fenomeni esterni alle ghiandole: la carenza di vitamina D, l’insufficienza renale cronica, il malassorbimento di nutrienti a livello intestinale possono provocare un’ipocalcemia costante che induce le paratiroidi a rilasciare continuamente grandi quantità di ormone.
Gli effetti dannosi dell’iperparatiroidismo sono dovuti all’ipercalcemia cronica, che causa:
- disturbi a carico del sistema nervoso (depressione, difficoltà di concentrazione, dolori diffusi)
- anomalie dell’attività muscolare (ipostenia)
- alterazioni del tessuto osseo (osteopenia, osteopatia fibroso-cistica)
- calcolosi renale
- deposizione di calcio nelle pareti vascolari (aterosclerosi).
Un po’ meno comune è la condizione di ipoparatiroidismo causata nella maggior parte dei casi dall’asportazione chirurgica delle paratiroidi (necessaria in presenza di patologie che interessano le ghiandole stesse o strutture adiacenti) oppure più raramente da un processo infiammatorio di natura autoimmune o da una malattia congenita.
I sintomi dell’ipoparatiroidismo sono legati ai bassi livelli di calcio nel sangue, che determinano in primo luogo uno stato di ipereccitabilità neuromuscolare (spasmi muscolari, accentuazione dei riflessi tendinei, disturbi della sensibilità).
Se si verificano in modo acuto, sia l’aumento sia la diminuzione dei livelli ematici di calcio provocano quadri clinici gravi (crisi paratireotossica nel primo caso, sindrome tetanica nel secondo), che richiedono il ricovero immediato in ospedale.
Diagnosi e trattamento delle disfunzioni paratiroidee
I principali esami diagnostici indicati per l’inquadramento di una disfunzione paratiroidea sono:
- i test di laboratorio che valutano l’attività endocrina delle paratiroidi e il metabolismo del calcio e del fosforo (dosaggio ematico del paratormone, misurazione delle concentrazioni dei due minerali nel sangue e nelle urine)
- le indagini radiologiche che consentono di visualizzare lo stato delle ghiandole (ecografia, scintigrafia, risonanza magnetica)
- le indagini radiologiche che valutano gli eventuali effetti della disfunzione sull’apparato scheletrico (radiografia, densitometria ossea).
Per quanto riguarda il trattamento, in caso di iperparatiroidismo primitivo si impone l’asportazione chirurgica della/e ghiandola/e malata/e oppure, qualora l’intervento non sia fattibile, una terapia medica mirata a limitare i danni ossei (con farmaci per l’osteoporosi).
In caso di iperparatiroidismo secondario è indicata invece la correzione delle carenze di nutrienti che lo determinano oppure, soprattutto in presenza di insufficienza renale, la somministrazione di farmaci capaci di modulare l’attività dei recettori delle cellule paratiroidee (calcio-mimetici).
Infine, in caso di ipoparatiroidismo è necessaria l’integrazione di calcio e vitamina D.