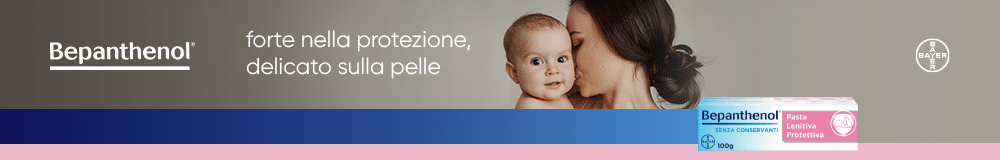- Sono malattie genetiche ereditarie
- Neurofibromatosi NF1: i sintomi
- NF1 in età infantile
- Neurofibromatosi NF2: i sintomi
- La diagnosi di NF2
- Le terapie per le neurofibromatosi
Un solo termine per indicare un insieme di malattie genetiche che predispongono a sviluppare tumori del sistema nervoso.
Quando si parla di neurofibromatosi non si fa riferimento a un’unica malattia genetica, ma a più di una patologia, con alcune caratteristiche in comune. Sono sostanzialmente due le più note, ossia le neurofibromatosi tipo NF1 e NF2.
La NF1, conosciuta anche come malattia di von Recklinghausen, è la forma più frequente, e colpisce circa una persona ogni 3.500. La neurofibromatosi NF2, invece, è più rara e colpisce circa una persona ogni 40.000, ma è anche più grave. Scopriamole insieme.
Sono malattie genetiche ereditarie
Entrambe le forme di neurofibromatosi citate sono malattie genetiche, cioè legate ad alterazioni di geni specifici. Ogni gene è costituito da una piccola sequenza di DNA che codifica una specifica proteina, e una sua alterazione corrisponde a un errore all’interno di tale sequenza, a causa del quale la proteina che ne deriva risulta difettosa o assente.
In questo caso specifico, la malattia di von Recklinghausen è dovuta alla mutazione del gene NF1 (individuato nel 1990) posizionato sul cromosoma 17, mentre la NF2 a una mutazione del gene omonimo (individuato nel 1993) posizionato sul cromosoma 22. I due geni codificano rispettivamente per le proteine neurofibromina 1 e neurofibromina 2 (chiamata anche merlina o schwannomina) che funzionano da oncosoppressori, cioè contrastano la proliferazione delle cellule tumorali. Di conseguenza, il difetto genetico si traduce nella predisposizione a sviluppare tumori che, nel caso specifico, riguardano il sistema nervoso.
Sono entrambe malattie ereditarie a trasmissione autosomica dominante: autosomica perché entrambi i geni coinvolti sono localizzati su una delle 22 coppie di cromosomi che non contengono informazioni genetiche specifiche alla caratterizzazione sessuale dell'individuo (chiamati per questo autosomi); dominante perché basta una singola copia dell'allele (ogni gene possiede due alleli, uno proveniente dall'informazione genetica del padre, l'altro da quello della madre) difettoso per far sì che il carattere patologico (quindi la malattia) si esprima.
Ne consegue che in una coppia, basta che un solo genitore abbia una mutazione del gene per avere il 50% di probabilità, a ogni gravidanza, di trasmettere la mutazione al figlio, indipendentemente dal sesso.
L’alterazione del gene può però svilupparsi anche senza essere stata ereditata da uno dei due genitori: e infatti in circa la metà dei casi la diagnosi di neurofibromatosi avviene in assenza di una storia familiare per questa malattia.
Neurofibromatosi NF1: i sintomi
Le manifestazioni della neurofibromatosi 1 sono estremamente variabili. Alcuni sintomi più di altri tendono a essere presenti nella maggior parte dei soggetti malati e si tratta di:
- macchie caffelatte, lesioni cutanee piatte, dai contorni definiti ma forma e dimensione variabile, che compaiono in genere su tronco e arti, a volte già alla nascita o comunque nei primi mesi di vita, aumentando di numero e dimensioni nei corso dell’infanzia (fino ai 5-6 anni). Rappresentano spesso il primo segno della malattia
- lentiggini, piccolissime macchioline localizzate in particolare alle ascelle, all’inguine e alla base del collo, da ambo le parti, che compaiono in genere a partire dai 5 anni di età, aumentando eventualmente di numero fino alla pubertà
- noduli di Lisch, noti anche come amartomi dell’iride, una sorta di piccole macchie oculari in rilievo, di colore giallo-marrone, che tendono a comparire poco prima della pubertà e che possono essere rilevate solo con una visita oculistica specialistica
- neurofibromi (che danno il nome alla malattia), ossia tumori benigni che hanno origine dalla guaina dei nervi periferici, di tipo cutaneo e/o sottocutaneo. In genere si sviluppano gradualmente, ma il numero e la localizzazione sono molto variabili da persona a persona. I neurofibromi cutanei sembrano piccole protuberanze di consistenza molle che si formano lungo il decorso dei nervi a livello della superficie cutanea, tendono a manifestarsi con la crescita e sono presenti in quasi tutti i pazienti adulti. I neurofibromi sottocutanei sono meno frequenti dei cutanei, interessano in genere le radici dei nervi o i tronchi dei nervi periferici principali e sono di consistenza generalmente più dura.
Riguardano invece solo circa il 30% dei pazienti, anche se possono essere presenti sin dall’infanzia, i cosiddetti neurofibromi plessiformi, che si formano lungo i nervi principali, e, a differenza dei precedenti, si sviluppano in larghezza, con contorno poco definiti, tanto che al tatto sembrano un fascio di noduli, raggiungendo anche dimensioni tali da avere conseguenze estetiche e/o funzionali. Possono anche risultare dolorosi ed esiste la rara possibilità che, col tempo, possano evolvere in neoplasie maligne (come sarcomi dei tessuti molli).
In una discreta fetta di pazienti si riscontrano anche:
- bassa statura
- macrocefalia (crescita anomala del volume del capo)
- malformazioni del torace.
Altri sintomi sono spesso considerati complicanze della malattia:
- disturbi dell’apprendimento (riscontrati in un 40-60% dei casi)
- sindrome da deficit di attenzione e iperattività
- glioma (tumore cerebrale che colpisce il nervo ottico, presente nel 15-20% dei casi, con insorgenza durante la prima infanzia)
- anomalie ossee, come la displasia dello sfenoide (un osso della base del cranio), la displasia delle ossa lunghe, soprattutto della tibia, la pseudoartrosi della tibia, e la scoliosi
- cefalea
- ipertensione
- convulsioni
- malattie cerebrovascolari
- stenosi dell’acquedotto cerebrale (complicanza rara che porta a idrocefalo).
Ci sono casi in cui insieme alla neurofibromatosi NF1 può essere diagnosticata la sclerosi multipla: ciò accade in conseguenza di una particolare mutazione che coinvolge un segmento del gene NF1, detto introne, su cui è localizzata una proteina che è coinvolta nella mielinizzazione, il processo di formazione della guaina mielinica del sistema nervoso centrale (la sclerosi multipla è caratterizzata proprio da aree in cui la guaina mielinica è distrutta).
I soggetti con neurofibromatosi di tipo NF1 hanno inoltre un rischio maggiore rispetto a quello della popolazione generale di sviluppare un tumore maligno (per esempio tumori del sistema nervoso centrale, ma anche carcinoma della mammella).
NF1 in età infantile
Secondo quanto stabilito dal National Institute of Health, la diagnosi di neurofibromatosi NF1 richiede un esame clinico completo, associato anche a esame del fondo oculare, e viene posta con certezza solo quando sono presenti almeno due segni clinici tra:
- sei o più macchie caffelatte (di dimensioni maggiori di 5 mm in età infantile, superiori ai 15 mm dopo la pubertà)
- lentiggini
- due o più noduli di Lisch
- due o più neurofibromi cutanei/sottocutanei o almeno un neurofibroma plessiforme
- glioma del nervo ottico
- lesioni ossee tipiche
- parente di primo grado affetto da NF1.
In genere la malattia si manifesta entro i sei anni di vita, anche se i vari segni clinici compaiono a età diverse. Per questo, nei bambini con un solo segno clinico la diagnosi può essere confermata ricorrendo a test genetici (test di analisi molecolare del DNA per ricercare la mutazione del gene specifico).
Alla diagnosi segue una consulenza genetica rivolta al malato e ai familiari, per spiegare la malattia e il suo impatto. Segue, inoltre, un monitoraggio periodico (generalmente annuale, almeno nei primi anni) del paziente, con un’équipe multidisciplinare di esperti, per ricercare e tenere sotto controllo eventuali complicanze, a seconda dell’età. In genere anche il monitoraggio prevede un esame clinico e solo in caso di sospetti di complicanze può essere valutato il ricorso a ulteriori accertamenti strumentali.
Nelle famiglie a rischio con mutazione genetica identificata è possibile effettuare una diagnosi prenatale (attraverso amniocentesi o villocentesi).
Neurofibromatosi NF2: i sintomi
La neurofibromatosi NF2 è caratterizzata dallo sviluppo di tumori al sistema nervoso centrale e periferico appartenenti al gruppo degli:
- schwannomi o neurinomi (tumori benigni originati dalle cellule di Schwann)
- meningiomi (tumori quasi sempre benigni che si originano dalla membrana più esterna che avvolge l’encefalo e il midollo spinale)
- astrocitomi
- ependimomi (tumori cerebrali che originano nelle cellule ependimali).
Si tratta di tumori per lo più benigni, ma comunque in grado, vista la loro localizzazione, di determinare gravi disabilità e deficit neurologici, con esiti anche fatali in giovane età.
In particolare, in circa l’85-90% dei casi, si manifesta uno schwannoma vestibolare al nervo acustico, a volte da un solo lato ma più spesso bilaterale, che comporta generalmente deficit dell’udito (fino alla sordità) vertigini, acufeni, disturbi dell’equilibrio (con anche ostacoli alla deambulazione).
In un’alta percentuale di casi (attorno all’80%) si riscontra anche la presenza di cataratta congenita.
Anche in questa forma di neurofibromatosi, inoltre, si riscontrano spesso tumori a livello cutaneo e sottocutaneo, ma si tratta più frequentemente di schwannomi (rarissimi i neurofibromi). Possono, inoltre, essere presenti macchie caffelatte, ma in meno della metà dei pazienti e in numero generalmente più basso di quello riscontrato nella NF1.
La diagnosi di NF2
La diagnosi di neurofibromatosi NF2 richiede un esame clinico, associato a visita oculistica, controllo uditivo (audiometria e potenziali evocati del tronco cerebrale) e risonanza magnetica cerebrale e spinale. Per porre la diagnosi, è necessaria la presenza di un “criterio maggiore” più eventuali “criteri aggiuntivi”.
| Criteri maggiore | Criteri aggiuntivi |
|---|---|
| Schwannoma vestibolare bilaterale | |
| Un parente di primo grado con NF2 | Schwannoma vestibolare unilaterale |
| Un parente di primo grado con NF2 | Almeno due tra: meningioma, glioma, schwannoma, opacità sottocapsulari posteriori del cristallino |
| Schwannoma vestibolare bilaterale | Almeno due tra: meningioma, glioma, neurofibroma, schwannoma, opacità sottocapsulari posteriori del cristallino |
| Meningiomi multipli | Schwannoma vestibolare unilaterale |
| Meningiomi multipli | Almeno due lesioni tra: glioma, schwannoma, neurofibroma, cataratta giovanile |
Chi ha una storia familiare di NF2, dovrebbe sottoporsi a un controllo oculistico già nei primi due anni di vita e poi a una serie di controlli in presenza o in assenza dei sintomi della malattia. Anche in questo caso, nelle famiglie a rischio con mutazione genetica identificata è possibile effettuare una diagnosi prenatale.
Una volta posta la diagnosi, oltre alla consulenza genetica per malato e familiari, è necessario pianificare un monitoraggio periodico (in genere annuale, coinvolgendo un’équipe multidisciplinare composta da neurologi e neurochirurghi, genetisti, otorino, oculista, psicologo, fisioterapista, logopedista ecc.) che preveda:
- esame neurologico
- controllo oculistico e uditivo
- risonanza magnetica cerebrospinale.
Le terapie per le neurofibromatosi
Per entrambe le forme di neurofibromatosi non esiste al momento una cura specifica e risolutiva, ma si interviene per gestire le problematiche connesse ai sintomi e prevenire (quando possibile) o comunque trattare le complicanze (che sono le principali cause di morbilità della malattia).
Nella NF1 può essere effettuata la correzione, anche chirurgica, delle lesioni ossee (per esempio di alcune forme di scoliosi), così come può essere effettuato il trattamento chirurgico o con laser dei neurofibromi cutanei (in quelli sottocutanei e plessiformi la rimozione va invece valutata attentamente e limitata a casi specifici). Nei casi di gliomi che progrediscono rapidamente o sono di grosse dimensioni, si può ricorrere a chemioterapia ed, eventualmente, alla chirurgia. Terapie mediche possono essere utilizzate contro problematiche come l’ipertensione, le cefalee ecc. Necessario, inoltre, il supporto psicologico e riabilitativo (soprattutto in presenza di disturbi dell’apprendimento).
Nella NF2, la chirurgia dei tumori cerebrali e midollari è molto complessa e rischiosa e per questo limitata ai casi in cui le neoplasie crescono eccessivamente e/o determinano importanti deficit neurologici. È possibile, inoltre, per esempio intervenire chirurgicamente sulla cataratta e contrastare i deficit uditivi con interventi ad hoc (per esempio con impianti cocleari). Ancora più prezioso è poi in questi casi il supporto psicologico e riabilitativo multidisciplinare.