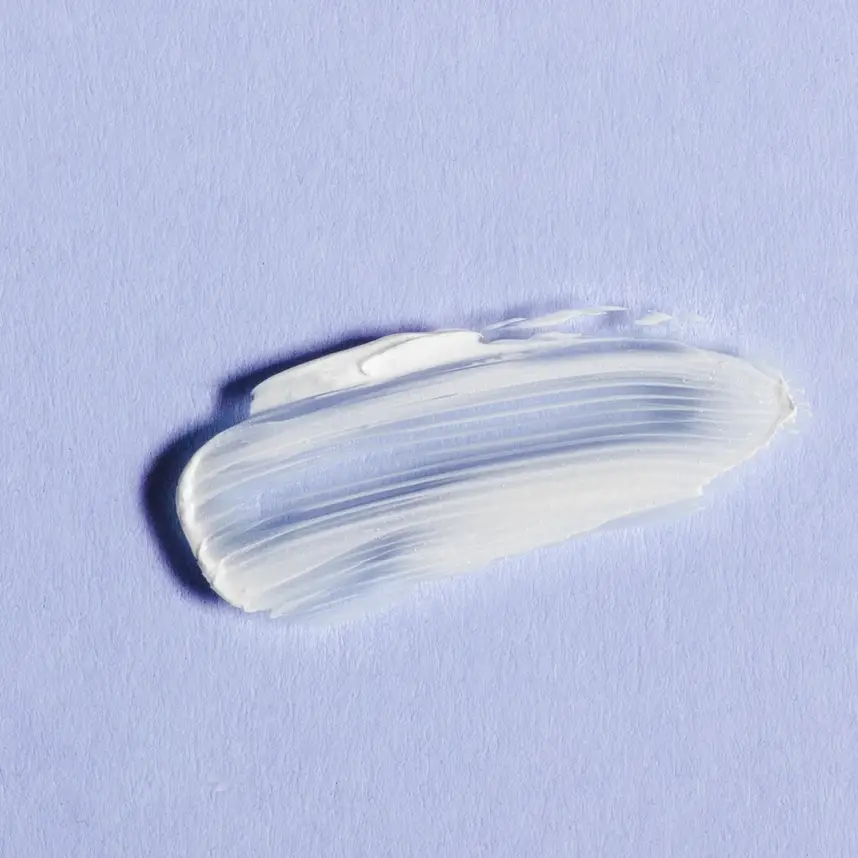Indice
Se non trattata, la sifilide può diventare potenzialmente mortale e causare gravi danni al cuore, al cervello e ad altri organi.
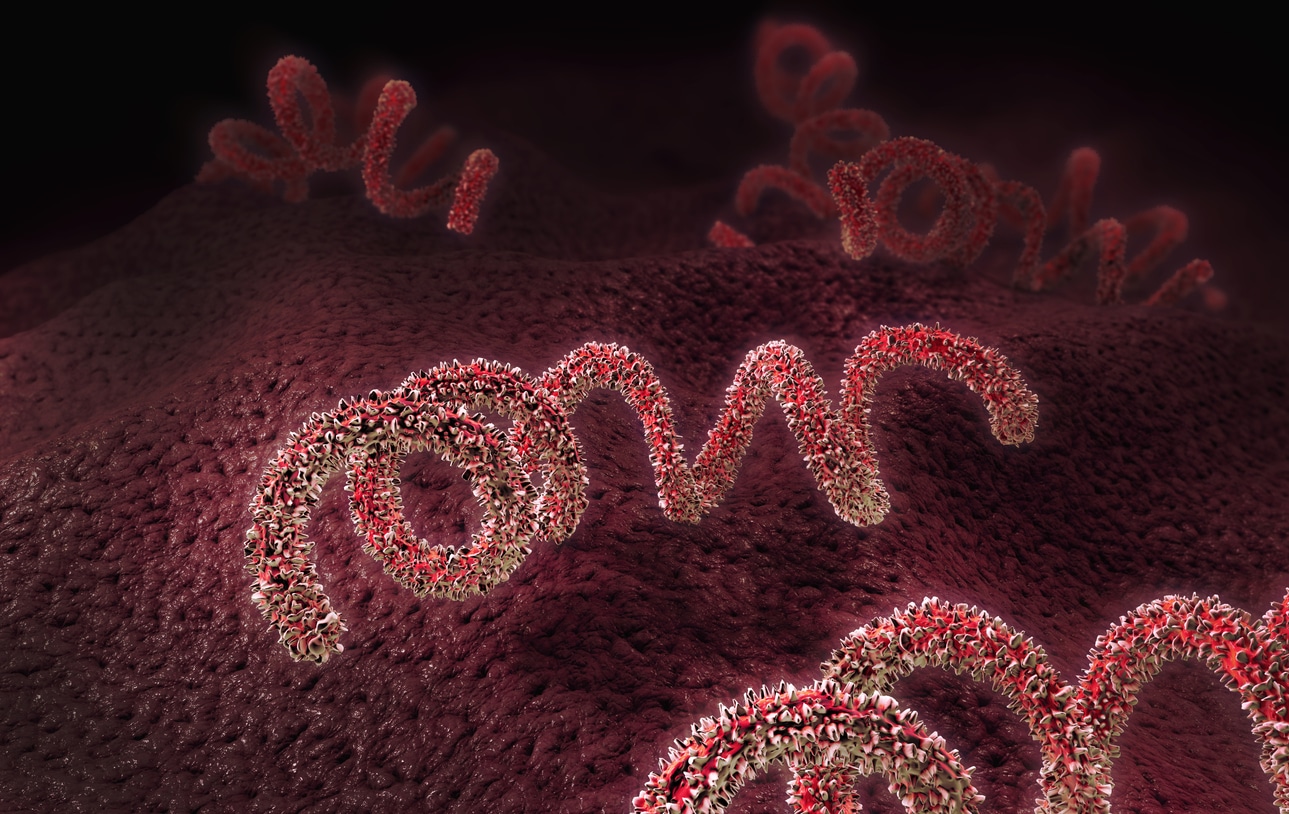
Epidemiologia e prevalenza della sifilide
- Si stima che nel 2020 in tutto il mondo ci siano stati 7 milioni di nuovi contagi da sifilide.
- Secondo i dati dell’Unione Europea, nel 2019, i tassi di sifilide segnalati sono stati 9 volte più alti negli uomini che nelle donne, con il maggior numero di contagi tra gli uomini nella fascia di età 25-34.
- Più del 60% dei nuovi casi si registra nei Paesi a basso e medio reddito.
- Il 74% dei casi riguarda uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM).
- Tra il 2010 e il 2017, il numero di casi di sifilide negli MSM è aumentato progressivamente, registrando un calo solo negli anni successivi. Nel periodo citato, si sono registrate fluttuazioni molto ridotte dei casi di sifilide tra gli eterosessuali.
- Il tasso stimato di prevalenza e incidenza della sifilide varia notevolmente tra regioni e paesi, con la prevalenza più alta in Africa. Questa, inoltre, è anche la regione che registra il più alto tasso di sifilide trasmessa per via materna, con più del 60% dei casi stimati nel mondo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha fissato obiettivi ambiziosi per ridurre l’incidenza della sifilide del 90% entro il 2030, ma la risposta globale è stata lenta.
Sintomi
La sifilide si sviluppa in quattro stadi: primario, secondario, latente e terziario. Ogni stadio è caratterizzato da segni e sintomi diversi.
Stadio primario
- Durante il primo stadio della sifilide, si può notare una singola lesione (nota anche come sifiloma) o lesioni multiple. La lesione segna il punto in cui la sifilide è penetrata nel corpo.
- Di solito, le lesioni compaiono:
- sul pene;
- nella vagina;
- in prossimità dell’ano;
- nel retto;
- in bocca o sulle labbra.
- Le lesioni sono generalmente (ma non sempre) dure al tatto, tondeggianti e indolori. Essendo spesso indolori, possono facilmente passare inosservate.
- Le lesioni durano in genere dalle 3 alle 6 settimane e guariscono indipendentemente dal trattamento; tuttavia, anche dopo la scomparsa della lesione, i soggetti non devono interrompere la cura, poiché questa impedisce il passaggio dell’infezione allo stadio secondario.
- Nello stadio primario della sifilide i soggetti possono anche presentare linfoadenopatia regionale (l’ingrossamento di un singolo linfonodo o di più regioni linfonodali contigue). I linfonodi interessati, in genere, non sono dolenti.
Stadio secondario
- Nello stadio secondario, il soggetto infetto in genere sviluppa un’eruzione cutanea su una o più zone del corpo, a volte sulle mani e/o sulla pianta dei piedi, che può diffondersi fino a ricoprire tutto il corpo. Inoltre, su bocca, vagina, pene o ano possono comparire lesioni simili a verruche (condiloma lata).
- L’eruzione che si manifesta durante la sifilide secondaria è di solito:
- ruvida;
- rossa o bruno-rossastra;
- non pruriginosa.
- Possono insorgere anche altri sintomi, tra cui:
- febbre;
- affaticamento;
- mal di gola;
- perdita di capelli a chiazze;
- mal di testa;
- perdita di peso;
- dolori muscolari;
- lesioni a chiazze all’interno della bocca;
- linfoadenopatia regionale.
- I segni e i sintomi della sifilide secondaria possono sparire in poche settimane o presentarsi in modo intermittente anche per un anno ma, se non trattata, la sifilide progredirà verso la fase latente.
Stadio latente
- Lo stadio latente della sifilide corrisponde a un periodo in cui, di solito, non ci sono sintomi o segni visibili; tuttavia, nei primi 4 anni di sifilide latente (stadio latente precoce), alcuni pazienti presentano recidive muco-cutanee (ricomparsa dei sintomi in aree muco-cutanee come i genitali, il retto e la bocca).
- Se il paziente presenta una recidiva, è da considerarsi infettivo. Dopo quattro anni (stadio latente tardivo), di solito non si presentano recidive e i pazienti sono considerati non infettivi (eccetto in caso di gravidanza o di ricezione di trasfusione sanguigna).
- Circa il 25% dei pazienti non sottoposti a trattamento durante lo stadio secondario della sifilide presentano una recidiva. Il 90% delle volte, questo si verifica nel primo anno di stadio latente.
- In assenza di trattamento, lo stadio latente può protrarsi per anni.
Stadio terziario
- La sifilide terziaria si sviluppa dai 10 ai 30 anni dopo l’infezione iniziale da T. pallidum.
- Nella maggior parte dei casi, la sifilide non trattata non progredisce allo stadio terziario ma, quando succede, può colpire cuore, cervello e sistema nervoso. Il danno che ne consegue può portare alla morte.
- Il 15-30% dei soggetti che non si sottopongono a trattamento in nessuno dei primi tre stadi della sifilide sviluppa la sifilide terziaria.
- Dal 1968 al 2015, negli Stati Uniti, si sono registrati 6.498 decessi attribuiti alla sifilide: 4.149 uomini e 2.349 donne.
Complicazioni della sifilide |
|
Qualità della vita
- Non sono molti gli studi moderni che si sono occupati della qualità della vita negli uomini e nelle donne affetti da sifilide; comunque, da molti studi emerge che le diagnosi di MST possono causare un notevole stigma sociale, intenso imbarazzo, paura della reazione del partner, violenza domestica o interruzione delle relazioni.
- In uno studio, i pazienti hanno riferito di provare un maggior senso di vergogna associato alla sifilide rispetto all’AIDS, ad altre MST e a varie condizioni cutanee invalidanti.

| La stigmatizzazione della sifilide nella storia |
| Cronache risalenti al XV secolo indicano che nel corso della storia la sifilide è stata percepita come un’infezione pericolosa, che ha causato allarmismo nella popolazione a causa della paura dovuta alla sua contagiosità e alle sue manifestazioni. Le persone erano spaventate dal contagio da sifilide anche perché all’epoca venivano prescritte “cure” altamente tossiche, come la terapia a base di metalli pesanti, quali il mercurio, gli arsenicali o il bismuto. |
Cause
- La sifilide è causata dal batterio Treponema pallidum, che penetra nel corpo attraverso piccoli tagli o abrasioni.
- Il T. pallidum, in genere, si diffonde tramite il contatto diretto con una lesione da sifilide durante il sesso vaginale, anale o orale.
- La sifilide può anche essere trasmessa verticalmente, cioè da una donna affetta da sifilide al bambino che porta in grembo.
- In rari casi, se una persona presenta lesioni da sifilide in bocca, l’infezione si può trasmettere anche attraverso i baci.
- La sifilide non si trasmette attraverso il contatto casuale con:
- sedili di WC;
- maniglie di porte;
- piscine, vasche da bagno e vasche idromassaggio;
- indumenti;
- utensili da cucina.
Sifilide: fattori di rischio
Il rischio di contrarre la sifilide aumenta in caso di:
- Rapporti vaginali, orali o anali non protetti
- Rapporti sessuali con più partner
- Rapporti sessuali tra persone di sesso maschile
- Infezione da HIV
- Positività del partner alla sifilide
- Contatto sessuale con sex worker o attività da sex worker
- Uno studio condotto su sex worker in Sudafrica ha rilevato che il 21% delle persone coinvolte aveva anticorpi che suggerivano un’infezione passata o in corso.
Diagnosi
- La sifilide è caratterizzata da manifestazioni varie e spesso poco evidenti, che rendono difficile la diagnosi clinica e fanno sì che molte infezioni non vengano riconosciute.
- L’esame sierologico (un test di laboratorio che verifica la presenza di anticorpi o altre sostanze in un campione di sangue) è diventato il mezzo più comune per diagnosticare la sifilide nelle persone con sintomi e in quelle che non presentano sintomi ma vengono individuate tramite screening.
- I test sierologici per la sifilide possono essere classificati a grandi linee in Test Non Treponemici (NTT) e Test Treponemici (TT):
- I test NTT misurano le immunoglobuline (IgM e IgG) prodotte in risposta al materiale rilasciato dal batterio e/o dalle cellule ospiti morenti. I test NTT non diventano positivi fino a 10-15 giorni dopo l’insorgenza della lesione primaria;
- I test TT rilevano gli anticorpi che attaccano le proteine di T. pallidum. I test TT diventano positivi dopo 6-14 giorni dall’insorgenza della lesione primaria (circa 5 settimane dopo l’infezione). Possono quindi essere utili per individuare la sifilide allo stadio iniziale che non viene rilevata dal test NTT.
- I test sierologici per la sifilide possono essere classificati a grandi linee in Test Non Treponemici (NTT) e Test Treponemici (TT):
- Un operatore sanitario può anche prelevare un tampone dalla lesione sospetta e inviarlo in laboratorio per farlo analizzare.

Diagnosi differenziale
- Per via delle sue manifestazioni variabili, spesso poco evidenti e che possono imitare quelle di altre infezioni, la sifilide si è guadagnata i soprannomi di “Grande Imitatore” e “Grande Impostore”.
- A seconda dello stadio, la sifilide può assomigliare a diverse altre condizioni.
Sifilide primaria
Se il soggetto presenta una lesione che appare simile a quelle che si verificano nello stadio primario della sifilide, le diagnosi differenziali dipendono dalla localizzazione della piaga:
- Area genitale
- Herpes genitale
- Balanite (gonfiore e irritazione della sommità del pene)
- Lesioni traumatiche secondarie infette
- Linfogranuloma venereo (MST causata da un particolare tipo di batterio della clamidia)
- Sindrome di Behçet (malattia rara che causa l’infiammazione dei vasi sanguigni in tutto il corpo)
- Cancro ai genitali
- Cancroide (infezione batterica che provoca dolore e ulcere superficiali)
- Area perianale
- Infezione da herpes simplex
- Ragade anale
- Morbo di Crohn (condizione infiammatoria di alcune parti dell’apparato digerente)
- Cancro anale
- Cervice
- Cancro cervicale
- Herpes cervicale
- Erosione cervicale
- Mucosa orale
- Infezione da herpes simplex
- Stomatite aftosa (condizione diffusa che provoca frequenti episodi di ulcere alla bocca)
- Sindrome di Behçet
- Infezione secondaria di lesioni traumatiche
- Pemfigo (rara malattia cutanea che causa la formazione di vesciche sulla pelle e sulle membrane mucose)
- Pemfigoide (condizione rara che causa grosse vesciche piene di liquido sulla pelle)
- Reazioni ai farmaci
- Cancro alla bocca
Se il soggetto presenta una linfoadenopatia regionale, le diagnosi differenziali sono ampie e possono includere cause infettive, malattie sistemiche e tumori maligni.
Sifilide secondaria
- Se il soggetto presenta un’eruzione cutanea, le diagnosi differenziali includono:
- Se il soggetto presenta i condiloma lata, le diagnosi differenziali includono:
- Papillomavirus umano
- Mollusco contagioso (un’infezione virale che provoca macchie sulla pelle)
- Emorroidi (se interessano l’area anale)
- Se il soggetto presenta una perdita di capelli a chiazze, le diagnosi differenziali includono:
- Alopecia areata (perdita di capelli a chiazze)
- Alopecia cicatriziale (condizione infiammatoria che distrugge i follicoli piliferi, causando cicatrici e perdita permanente dei capelli)
- Tinea capitis (tigna del cuoio capelluto: un’infezione fungina che provoca un’eruzione cutanea)
- Se il soggetto presenta lesioni a chiazze all’interno della bocca, le diagnosi differenziali includono:
- Cancro alla bocca
- Ulcere aftose
- Mononucleosi infettiva (se le ulcere sono presenti sulle tonsille)
- Se il soggetto presenta una linfoadenopatia regionale, le diagnosi differenziali sono ampie e possono includere cause infettive, malattie sistemiche e tumori maligni.
Sifilide terziaria
Le diagnosi differenziali della sifilide terziaria sono ampie e possono includere:
- Demenza
- Disturbi psichiatrici
- Patologie che influiscono sulla mobilità
- Lesioni granulomatose croniche della tubercolosi
- Sarcoidosi (condizione che provoca lo sviluppo di piccole chiazze di tessuto rigonfio in uno o più organi, chiamate granulomi)
- Lebbra
Linee guida per il trattamento della sifilide
Il trattamento preferibile per i pazienti adulti affetti da sifilide, indipendentemente dallo stadio, consiste in 2,4 milioni di unità di penicillina G benzatina, somministrata con iniezione intramuscolare (IM) in dose singola.
- I soggetti che hanno avuto – a meno di 90 giorni dalla diagnosi – contatti sessuali con una persona a cui è stata diagnosticata la sifilide primaria, secondaria o in stadio latente precoce devono ricevere presuntivamente trattamenti per la sifilide anche se il test sierologico risulta negativo.
- I soggetti che hanno avuto – a più di 90 giorni dalla diagnosi – contatti sessuali con una persona a cui è stata diagnosticata la sifilide primaria, secondaria o in stadio latente precoce devono ricevere presuntivamente trattamenti per la sifilide se i risultati del test sierologico non sono immediatamente disponibili e se la possibilità di follow-up è incerta.
Nel trattamento dei bambini, la dose viene ridotta a 50.000 unità per kg di peso corporeo.
Sifilide: prevenzione
Se si è contratta la sifilide in passato non significa che non ci si possa infettare nuovamente. Le persone sessualmente attive possono minimizzare il rischio di contrarre la sifilide se:
- intrattengono relazioni monogame di lunga durata con un partner che si è sottoposto al test e non ha la sifilide;
- si astengono dai contatti sessuali con una persona che presenta i sintomi della sifilide o se si sospetta l’infezione;
- Usano il preservativo in maniera corretta ogni volta che hanno rapporti sessuali: in via generale, il preservativo previene la diffusione della sifilide impedendo il contatto con la lesione; tuttavia, a volte le lesioni si trovano in punti non coperti dal preservativo e il contatto con queste lesioni può determinare la trasmissione della sifilide.

Per evitare che la sifilide venga trasmessa o provochi danni ai nascituri, gli esperti raccomandano a tutte le donne incinte di sottoporsi al test per la sifilide.